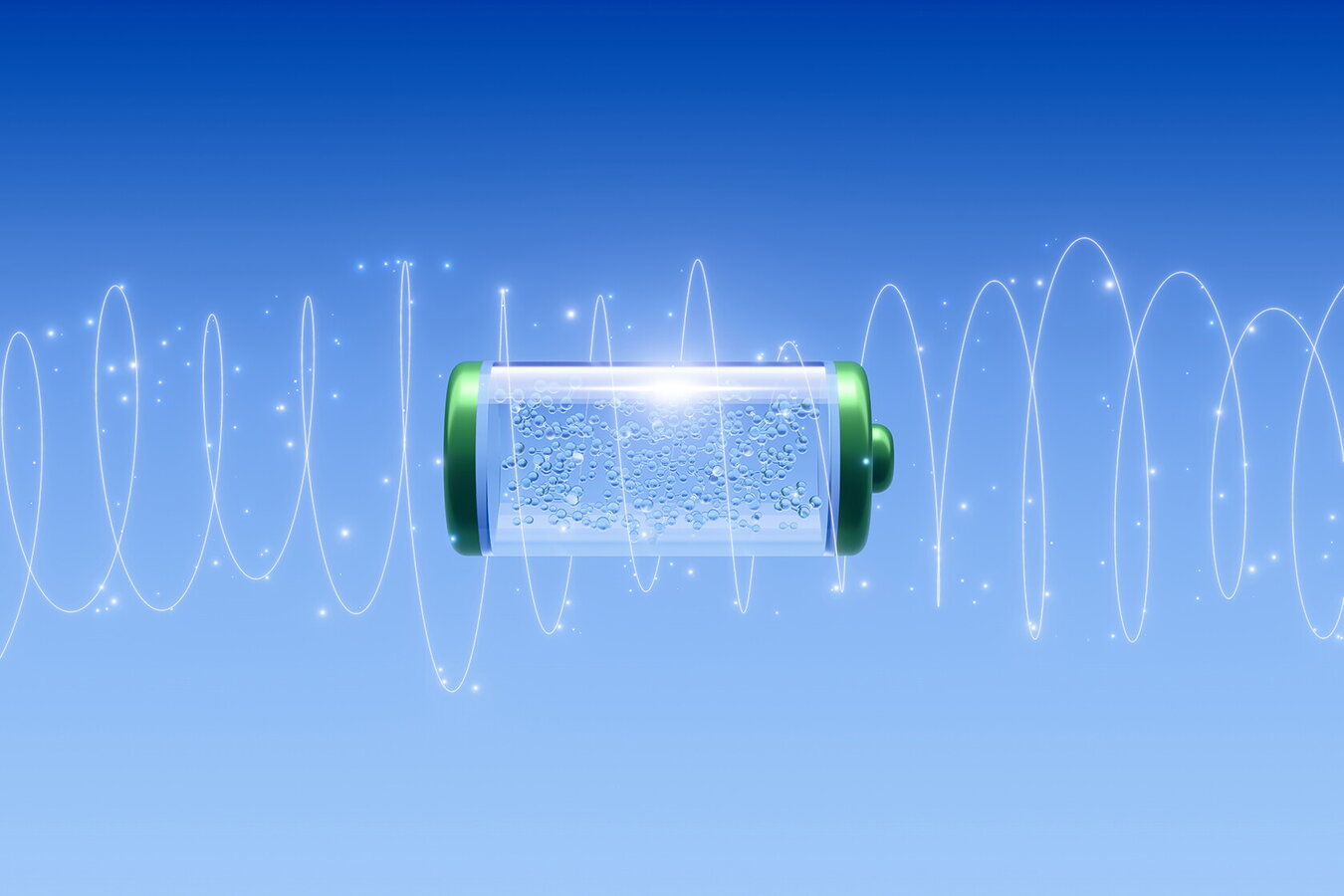
La corsa all’idrogeno di USA & Cina
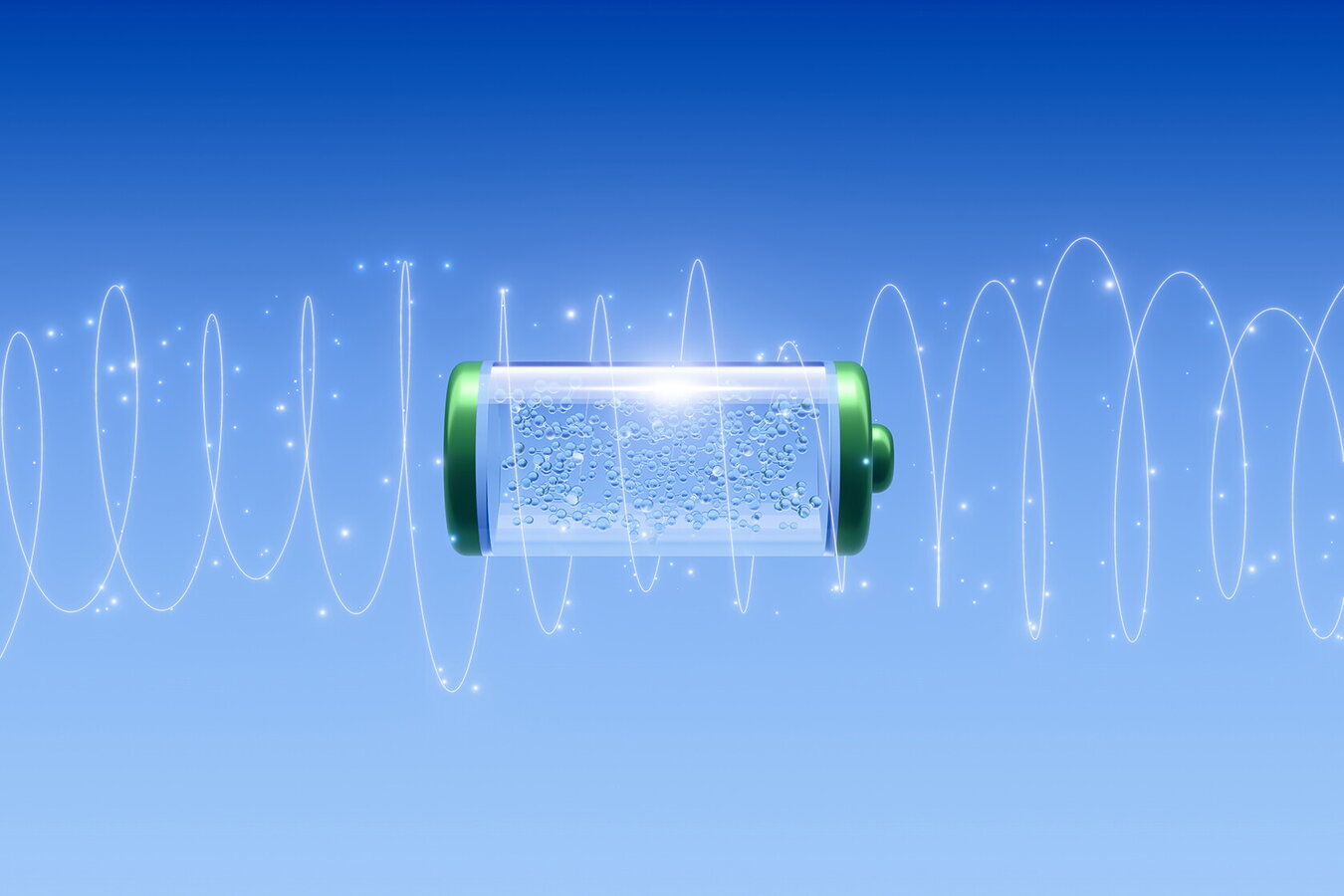
I
l sistema energetico globale prende le distanze dai combustibili ad alta intensità di carbonio e l’idrogeno è sempre più centrale nelle strategie per la decarbonizzazione di settori in cui è particolarmente difficile ridurre le emissioni, i cosiddetti “hard-to-abate”, come l’industria pesante, il trasporto via mare, l’aviazione e il commercio marittimo. Inoltre, l’idrogeno può fungere anche da mezzo di stoccaggio per stabilizzare le reti elettriche, a fronte del costante aumento della quota di elettricità generata a livello mondiale da energia eolica e solare volatile.
In tale contesto, decisori politici ed esperti nutrono da tempo la speranza che il mercato dell’idrogeno, una volta ingranata la marcia, possa cambiare radicalmente la geopolitica del commercio e dei flussi energetici, promuovendo l’indipendenza energetica, riducendo i rischi associati all’energia fossile e rafforzando il commercio basato sul valore. Detto ciò, l’idrogeno è una fonte di energia ad alta intensità tecnologica e industriale, che presenta implicazioni significative nelle catene del valore e nelle filiere dei minerali critici, oltre che una logistica complessa. L’idrogeno ha quindi una sua geopolitica e l’interazione tra concentrazione di minerali, concorrenza tecnologico-industriale, vincoli sui trasporti e attuali dinamiche di potere geopolitico influenzerà la politica e il processo decisionale sull’idrogeno lungo l’intera catena del valore. In molti casi, nella corsa all’idrogeno le parti in causa mettono ancora al primo posto considerazioni di carattere socioeconomico, geopolitico e tecnopolitico rispetto alla questione climatica; pertanto, l’interesse e il posizionamento nella futura economia dell’idrogeno potrebbero essere molto diversi a seconda di questi fattori.
La catena del valore e di approvvigionamento
La catena del valore dell’idrogeno ha caratteristiche differenti da quella dei combustibili fossili e persino da quella dell’elettricità da fonti rinnovabili, in quanto presenta un ecosistema complesso e interconnesso per quanto riguarda la produzione di idrogeno gassoso e di derivati dell’idrogeno come l’ammoniaca. Può essere suddivisa in tre grandi segmenti (upstream, logistica midstream e applicazioni downstream) e in un altro segmento che li precede (le pre-chain), spesso trascurato ma essenziale (componenti industriali e lavorazione delle materie prime).
Le pre-chain, pur non essendo direttamente collegate all’idrogeno o ai derivati dell’idrogeno come prodotti finali, sono particolarmente importanti per la produzione di idrogeno, soprattutto dell’idrogeno verde, poiché comprendono le filiere delle materie prime e dei minerali critici/strategici necessari per l’idrogeno, come il nichel, i metalli del gruppo del platino (PGM), ma anche il silicio e il litio, nonché il processo di produzione dei pannelli solari, delle turbine eoliche e degli elettrolizzatori.
Il segmento upstream interessa la produzione di idrogeno da elettricità rinnovabile (idrogeno verde tramite elettrolisi, idrogeno giallo da energia nucleare), da gas naturale tramite il processo di steam reforming del metano o pirolisi con cattura del carbonio (idrogeno blu) e da steam reforming del metano tradizionale senza cattura del carbonio (il cosiddetto idrogeno grigio).
Il segmento midstream abbraccia le infrastrutture di stoccaggio, distribuzione e trasporto, come condotte (circa 4.000 km), navi, terminali di liquefazione e spedizione, e tecnologie di conversione come la sintesi dell’ammoniaca per il trasporto a lunga distanza (oltre i 5.000 km), mentre il segmento downstream ingloba le applicazioni finali nella mobilità (veicoli a celle a combustibile, trasporto pesante), nei processi industriali (acciaio, ammoniaca, raffinazione) e nella generazione di energia.
L’interconnessione riguarda in particolare le aree midstream e upstream: a seconda dell’uso finale, l’idrogeno e i suoi derivati hanno una catena del valore e una logistica di trasporto specifiche. Per produrre idrogeno sotto forma di gas o di derivato e utilizzarlo in loco o trasportarlo su lunghe distanze, occorrono processi chimici di diversa complessità. I cluster industriali in prossimità dei porti e dei rispettivi hinterland o vicini al consumatore finale definiscono la logistica (linee elettriche, condotte, navi, terminali di liquefazione e spedizione e tecnologie di conversione) e quindi riconfigurano la geografia economica del settore e dell’energia.
Oggi la carenza di infrastrutture industriali e per i trasporti viene spesso additata come l’elemento che impedisce il pieno sviluppo del mercato dell’idrogeno pulito. A fronte della scarsa capacità di immagazzinare e trasportare l’idrogeno in modo economico e sicuro su scala –e della scarsa capacità di produrre in massa elettrolizzatori o di sviluppare tecnologie abilitanti– gli investimenti nella produzione a monte e nella domanda a valle rimangono frammentati, isolati e incerti, e il costo dell’idrogeno, soprattutto quello da fonti rinnovabili, resta elevato. Senza parlare della difficoltà di estrarre, trattare e garantire l’approvvigionamento di materie prime critiche, necessarie soprattutto per la produzione di idrogeno verde.
Posizionamento strategico di Cina e Stati Uniti
Cina e Stati Uniti, che hanno un ruolo di primo piano nei mercati energetici e nella configurazione dell’ordine mondiale, vedono nell’idrogeno un ulteriore terreno di sfida nella corsa globale all’energia e nella loro rivalità geopolitica. I due paesi si contendono infatti la leadership nell’economia dell’idrogeno, riconoscendo il potenziale dell’idrogeno non solo nella transizione energetica interna, ma anche nella definizione dei futuri poteri globali. Tuttavia, la corsa al dominio dell’idrogeno non è né lineare né uniforme. Come accennato, si sviluppa attraverso catene del valore e di approvvigionamento complesse e interconnesse, in cui entrambi i paesi assumono ruoli diversi ma cruciali.
Né la Cina né gli Stati Uniti sono attualmente in grado o ansiosi di distinguersi come grandi esportatori di idrogeno, anche se entrambi potrebbero avere un ruolo fondamentale nella creazione di economie regionali dell’idrogeno e, potenzialmente, di un mercato globale dell’idrogeno. In particolare, i colli di bottiglia midstream e le priorità strategiche nazionali limitano l’influenza di queste potenze sui flussi internazionali di idrogeno, un ambito in cui paesi come Australia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sono molto più attivi poiché mirano a diventare grandi esportatori di idrogeno (principalmente idrogeno verde e blu sotto forma di ammoniaca) verso l’Asia orientale e l’Europa.
Tuttavia, le priorità geopolitiche, le specifiche capacità tecnologico-industriali e le risorse energetiche di Stati Uniti e Cina rappresentano leve fondamentali per influenzare lo sviluppo del mercato dell’idrogeno e la sua geopolitica nei prossimi decenni.
La strategia cinese: padronanza di pre-chain e segmenti upstream
Le ambizioni della Cina rispetto all’idrogeno poggiano su considerazioni in materia di sicurezza e indipendenza energetica, oltre che sulle aspirazioni in materia di sostenibilità e sulla politica industriale del paese. Tuttavia, la concorrenza strategica con gli Stati Uniti alimenta la corsa per la leadership tecnologica e di mercato anche nel settore dell’idrogeno. La Cina mira a produrre 0,1-0,2 milioni di tonnellate di idrogeno all’anno da energie rinnovabili entro il 2025, per posizionarsi come produttore autosufficiente e potenziale hub commerciale.
L’approccio cinese all’idrogeno è improntato a una rapida scalabilità e all’integrazione strategica in politiche industriali e ambientali a più ampio raggio. Il paese è il primo produttore al mondo di elettrolizzatori, grazie ad aziende come Longi e SinoHytec che stanno ampliando notevolmente la propria capacità produttiva. Nello specifico, la Cina si è guadagnata un posto di spicco nel mercato globale degli elettrolizzatori sfruttando le sue consolidate capacità produttive con la tecnologia di elettrolisi dell’acqua alcalina (ALK) e recuperando rapidamente terreno nella tecnologia delle membrane a scambio protonico (PEM). In qualità di raffinatore di molte materie prime –come il nichel (necessario per l’ALK) e i PGM critici (necessari per la PEM)– e di produttore leader di pannelli solari e turbine eoliche, la Cina è ben posizionata per la futura produzione di idrogeno.
Sono inoltre in corso progetti su larga scala relativi all’idrogeno anche in regioni ricche di fonti rinnovabili come la Mongolia interna e lo Xinjiang, con l’obiettivo di decarbonizzare l’industria pesante. Ma la Cina fa passi da gigante anche nella realizzazione di infrastrutture interne per l’idrogeno nel settore del trasporto pesante e all’inizio del 2025 contava già oltre 300 stazioni di rifornimento di idrogeno in funzione, più di qualsiasi altro paese. A ciò si aggiungono ingenti investimenti pubblici e privati nel quadro del piano di sviluppo dell’idrogeno 2021-2035 del governo centrale, che punta ad avere 50.000 veicoli a celle a combustibile in circolazione entro il 2025.
Tuttavia, l’economia cinese dell’idrogeno è per lo più circoscritta al mercato interno. A fronte di un mercato nazionale molto vasto e della geografia logistica della Cina, il consumo interno attrae più dell’esportazione, mentre ci sono vantaggi competitivi nella produzione industriale, nella lavorazione delle materie prime e nel know-how tecnologico. Di conseguenza, nel segmento midstream il paese si scontra con dei limiti, ma non ha alcun incentivo per superarli. Il trasporto dell’idrogeno è problematico a causa della sua bassa densità energetica e la Cina non dispone ancora di mezzi sufficienti per trasportare l’idrogeno liquido né di condotte per l’esportazione che la posizionerebbero come un importante fornitore di idrogeno a livello globale. Questa situazione è in linea con gli obiettivi strategici della Cina in materia di sicurezza e di autosufficienza tecnologica per quanto riguarda l’energia, poiché l’idrogeno è solo uno dei tanti strumenti per ridurre le emissioni di gas serra e garantire al contempo l’autosufficienza.
L’economia dell’idrogeno si svilupperà probabilmente nel lungo periodo assumendo la forma di una rete decentralizzata e regionale
Stati Uniti: una potenza tecnologica con priorità in evoluzione
Gli Stati Uniti potrebbero assumere lo speciale ruolo di prosumer (produttore e consumatore) con una potenziale influenza nel futuro mondo basato sull’idrogeno. Rispetto alla Cina, gli Stati Uniti hanno adottato un approccio all’idrogeno più frammentato ma ugualmente agnostico dal punto di vista tecnologico e altamente innovativo, con particolare riferimento all’agenda climatica dell’amministrazione Biden.
Negli ultimi anni, la Bipartisan Infrastructure Law e l’Inflation Reduction Act (IRA) hanno sostenuto il boom dell’idrogeno tramite generosi crediti d’imposta sulla produzione (fino a 3 dollari per chilogrammo di idrogeno verde) e finanziamenti per la creazione di hub dell’idrogeno in tutto il paese. Gli Stati Uniti sono all’avanguardia nell’innovazione upstream per quanto riguarda l’idrogeno verde, dal momento che possono vantare aziende leader nella tecnologia degli elettrolizzatori PEM. Ma hanno puntato anche sulla produzione di idrogeno blu, sfruttando le abbondanti risorse di gas naturale e l’esperienza nelle tecnologie di cattura del carbonio.
Sulla costa del Golfo sono in atto progetti per valutare le opportunità di esportazione dell’idrogeno, in particolare verso l’Europa e l’Asia. L’amministrazione Biden aveva anche iniziato a gettare le basi per la produzione di idrogeno blu su larga scala in Texas, in Louisiana e nella regione degli Appalachi. La strategia statunitense per l’idrogeno, pubblicata nel 2023, prevede una produzione interna annua di 10 milioni di tonnellate di idrogeno pulito entro il 2030, che dovrebbe salire a 50 milioni di tonnellate entro il 2050, una quantità potenzialmente superiore alla domanda interna a lungo termine che consentirebbe un margine per l’esportazione verso i paesi alleati.
Anche il settore downstream ha preso slancio, con l’integrazione dell’idrogeno nella produzione di ammoniaca e metanolo e nuovi progetti pilota di produzione di acciaio basata sull’idrogeno. Le case automobilistiche americane sono in ritardo rispetto alle controparti asiatiche per quanto riguarda i veicoli a celle a combustibile, mentre le partnership con aziende attive nella logistica e nel trasporto pesante (come Nikola e Cummins) fanno progressi in applicazioni di nicchia.
Tuttavia, come in Cina, negli Stati Uniti le infrastrutture midstream scarseggiano e non c’è grande interesse a investire in sistemi di trasporto H2-ready. Le condotte per l’idrogeno sono poche e concentrate per lo più nella regione della costa del Golfo. I terminali di liquefazione e di esportazione dell’idrogeno o dei suoi derivati (come l’ammoniaca) sono ancora limitati e la rete nazionale di rifornimento di idrogeno è meno sviluppata che in Europa o in Cina.
Inoltre, la nuova amministrazione Trump ha ridefinito le priorità delle politiche energetiche e climatiche, concentrandosi sul GNL piuttosto che sulla produzione e sull’esportazione di idrogeno e dando meno importanza alle tecnologie che mitigano i cambiamenti climatici come quella dell’idrogeno verde. Benché non abbia alcuna ripercussione sui crediti d’imposta, la sospensione dei finanziamenti ai sensi dell’IRA decisa dal Presidente Trump mette a rischio miliardi di finanziamenti a fondo perduto per l’idrogeno e i prestiti a grandi produttori come Plug Power. Nel frattempo, l’aumento dei dazi sui componenti solari ed eolici e sull’acciaio cinese farà lievitare ulteriormente i costi dei prossimi progetti rinnovabili, essenziali per la produzione di idrogeno verde.
Questi sviluppi potrebbero limitare il ruolo del paese come importante esportatore di idrogeno nel breve periodo, con conseguenze sia sulla produzione che sugli investimenti nelle infrastrutture di trasporto. Tuttavia, poiché la spinta degli Stati Uniti verso l’idrogeno pulito è alimentata anche dalla rivalità sistemica con la Cina, dalla crescente concorrenza tecnologico-industriale sia con la Cina che con l’Europa e dalla ricerca di resilienza nella catena di approvvigionamento di materiali e componenti critici, l’amministrazione Trump potrebbe comunque cercare di mantenere un vantaggio nelle tecnologie dell’idrogeno o addirittura promuovere la produzione e l’esportazione di idrogeno blu in ottica mercantilista.
In questo scenario, il superamento delle preoccupazioni ambientali e dell’opposizione politica legate all’idrogeno derivato da combustibili fossili (anche con cattura e stoccaggio del carbonio) favorirebbe le esportazioni di idrogeno blu e gli investimenti nelle infrastrutture, soprattutto se la corsa globale all’idrogeno si intensificasse o i prezzi del GNL scendessero abbastanza da rendere l’esportazione di idrogeno blu più interessante del GNL e persino più economica di quella dell’idrogeno verde, rispetto a quanto non lo sia già oggi.
Implicazioni geopolitiche per un’economia dell’idrogeno
Le divergenze tra Cina e Stati Uniti in termini di strategia e posizionamento nel settore dell’idrogeno hanno implicazioni geopolitiche molto ampie sulla futura economia dell’idrogeno. Nello specifico, lo sviluppo di infrastrutture per l’idrogeno –comprese logistica midstream, pre-chain industriali e segmenti upstream– non è solo una sfida tecnica o economica, ma anche un imperativo strategico.
In definitiva, la corsa all’idrogeno che vede contrapposti Cina e Stati Uniti non riguarda tanto la leadership nel commercio globale di idrogeno, quanto piuttosto la leadership tecnologica e industriale nella green economy che sta prendendo forma. Entrambi i paesi vogliono assicurarsi le componenti upstream e downstream della catena di approvvigionamento dell’idrogeno –attraverso la produzione nazionale, la ricerca e lo sviluppo (R&S), la produzione di componenti e l’integrazione verticale, aumentando al contempo la resilienza geoeconomica e il margine di manovra geopolitico– piuttosto che replicare il modello di esportazione del petrolio del XX secolo.
Tuttavia, questa competizione non ha carattere meramente economico, poiché le tecnologie dell’idrogeno implicano materie prime critiche (come iridio, platino e terre rare), processi di produzione all’avanguardia (membrane, catalizzatori) e la definizione di standard. Il controllo su questi fattori e tecnologie conferisce un vantaggio strategico pari o addirittura superiore al semplice controllo dei flussi di idrogeno e delle relative infrastrutture di trasporto. La Cina è un passo avanti nella lavorazione delle materie prime e nella produzione di elettrolizzatori, mentre gli Stati Uniti si distinguono nell’innovazione e per il dinamismo delle startup, sostenuti dagli ecosistemi di R&S accademici e federali.
In questo panorama geopolitico, le infrastrutture dell’idrogeno nel senso più ampio del termine, che comprendono ma trascendono i trasporti e la logistica sino a integrare la capacità industriale e manifatturiera, diventano uno strumento di modernizzazione interna ma anche un mezzo per esercitare influenza a livello internazionale e incrementare la resilienza geopolitica industriale. Sebbene i limiti midstream possano ancora frenare le possibilità di esportazione, la capacità di Cina e Stati Uniti di definire norme, standard e catene di approvvigionamento globali e l’evoluzione delle rispettive strategie nazionali e posizioni geopolitiche incideranno non solo sulle politiche sull’idrogeno di questi due paesi, ma anche sulle caratteristiche dell’era dell’idrogeno e della sua geopolitica.
Le sfide per l’Europa nella corsa all’idrogeno
A differenza del mercato del petrolio, che è altamente centralizzato e caratterizzato da pochi soggetti dominanti e colli di bottiglia (si pensi agli stretti marittimi e alle società di estrazione), l’economia dell’idrogeno si svilupperà probabilmente nel lungo periodo assumendo la forma di una rete decentralizzata e regionale. Le barriere tecnologiche, le differenze normative e i costi logistici favoriranno infatti la nascita di hub regionali e corridoi bilaterali, piuttosto che un mercato globale unificato.
Detto ciò, questo nuovo ordine in ambito energetico non sarà necessariamente più stabile o improntato alla cooperazione. Come dimostra la corsa all’idrogeno di Stati Uniti e Cina, la concentrazione di tecnologie e minerali critici, la frammentazione delle catene del valore, la concorrenza sul fronte industriale e i limiti infrastrutturali aumentano il rischio di interruzioni e conflitti commerciali. Soprattutto l’idrogeno verde e le sue catene di approvvigionamento diventano sempre più terreno di scontro geopolitico per la leadership industriale e tecnologica, oltre che per la sicurezza climatica.
La sfida per l’Europa come futuro importatore netto sarà quella di sviluppare una base industriale interna competitiva, garantire un accesso sicuro e sostenibile alle materie prime critiche, promuovere standard comuni presso i partner e rafforzare la cooperazione infrastrutturale. Solo così potrà avere una parte importante nella futura economia dell’idrogeno e ridurre la sua vulnerabilità a fronte di un sistema energetico frammentato.