
Transizione ecologica
La fine della globalizzazione
L’era neo-liberale e della globalizzazione è arrivata definitivamente al capolinea, mentre il mondo sta entrando dentro un nuovo interregno, una transizione dai contorni in parte chiarissimi e in parte ancora sfumati
13 minL’
anno che ci lasciamo alle spalle segna l’avvio di una transizione verso un mondo diverso più che una rottura decisiva col passato. Continuità e cambiamento si innestano su una storia che ha cominciato ad accelerare già dopo la crisi finanziaria del 2008, quando il vecchio sistema neoliberale, globalizzato e fondato sull’unipolarismo americano ha iniziato a entrare progressivamente in crisi. Mentre l’America di Obama e Trump innalzava barriere doganali e stabiliva un controllo serrato degli investimenti esteri, l’Unione europea annaspava nella crisi del debito e nel ritardo tecnologico, e nuovi autoritarismi come in Russia, Iran e soprattutto in Cina crescevano e si espandevano sullo scacchiere geopolitico. Ciò che aveva funzionato fino al 2008 iniziava a non funzionare più. Da qui i disordini statuali in nord-Africa, la recrudescenza del terrorismo islamico, la progressiva ritirata americana dall’Afghanistan, la presa della Crimea da parte russa nel 2014, le tensioni su Hong-Kong e Taiwan per le ambizioni cinesi. Cambiavano le relazioni internazionali e con esse l’economia e la politica interna.
Il ritorno dello Stato
Dopo il fallimento politico delle ricette di austerity nel periodo 2009-2013, riaffiorava un riluttante interventismo statale, per lo più monetario (quantitative easing), che si combinava con il protezionismo occidentale verso la Cina e le sanzioni alla Russia, infine si inauguravano nuove politiche economiche per tornare, pur lentamente, ad accrescere lo stock di investimenti. Il vecchio modello di globalizzazione e di restringimento monetario si piegava a nuove esigenze, tramontava l’epoca eredità dei Reagan e delle Thatcher, dei Clinton e dei Blair. Tuttavia, la politica accelerava e disordinava il quadro ancor più dell’economia: crescevano i populismi e i nazionalismi, periclitava la legittimazione dell’establishment e delle sue istituzioni, i governanti più accorti del vecchio ordine cercavano di sterzare verso un nuovo paradigma di maggior governo dell’economia e della società al fine di evitare il collasso repentino del vecchio sistema. Prendeva corpo un sistema ibrido: tecnocrazie e vecchie classi politiche attuavano riforme che venivano incontro ad un elettorato stanco, impoverito e attratto dai partiti nazional-populisti, mentre alcuni nuovi imprenditori della politica demagogica arrivavano al potere moderandosi e fondendosi con le vecchie strutture di potere. In questo processo di trasformazione e circolazione delle élite, in cui non mancheranno i fallimenti da una parte e dall’altra per difetto di realismo, i sistemi politici occidentali dimostreranno la propria plasticità e flessibilità a discapito di una visione idealizzata della rappresentanza democratica.
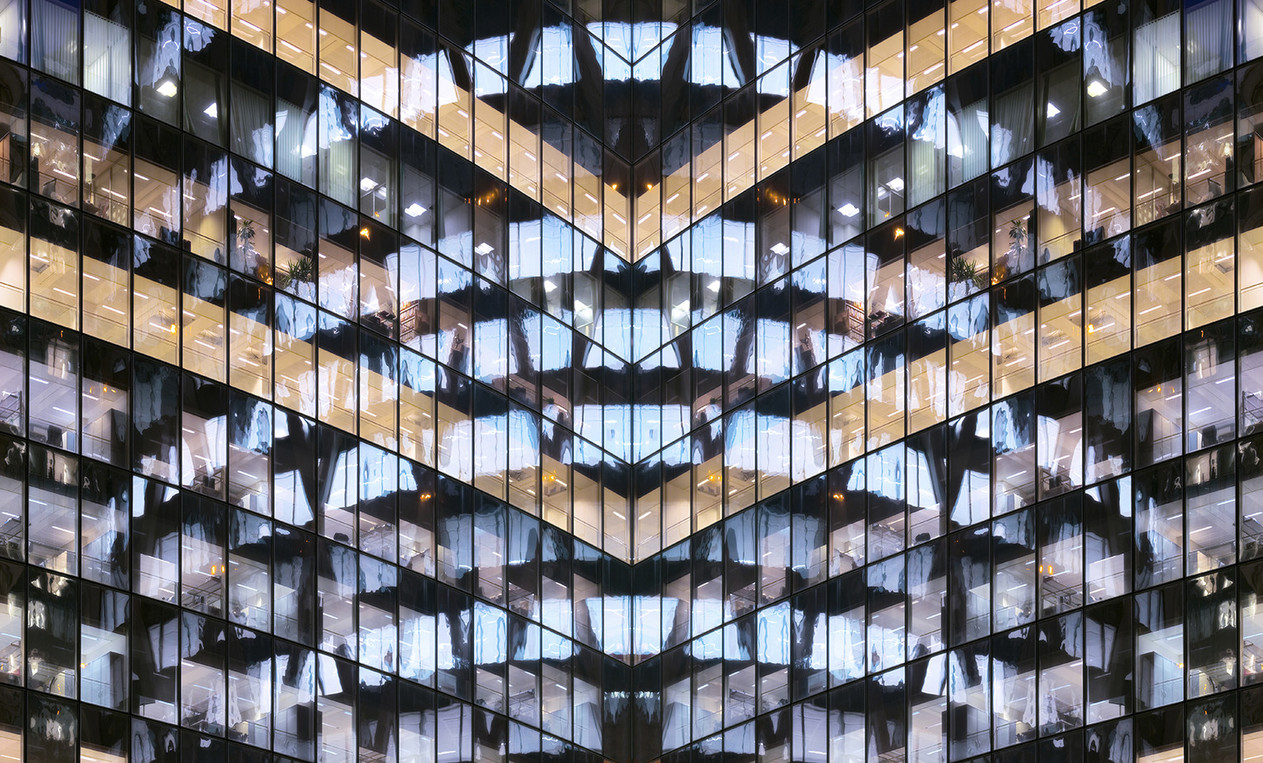
Nel frattempo, le relazioni internazionali si innervosivano, con gli Stati Uniti sempre più inclini a semplificare il sistema tra blocco occidentale, da essi egemonizzato, e un numero sempre più ristretto di nemici (Cina, Iran e Russia). Il vincolo atlantico tornava a stringersi in maniera più forte e determinante per tutti gli alleati sia nella proiezione estera degli “stati seguaci” di Washington che negli equilibri di politica interna.
È in questo scenario debilitato e irrigidito che nel 2020 si affaccia in un mondo sull’orlo del caos la pandemia di Covid-19. Essa conclude il cambio di paradigma economico, con il quantitative easing esteso, massicci stimoli fiscali di matrice governativa, l’esplosione dei deficit pubblici, nuovi investimenti pubblici nelle energie rinnovabili e nella tecnologia. La pandemia diviene, al tempo stesso, un’occasione per il vecchio establishment centrista di reinventarsi e frenare l’ascesa dei nuovi movimenti radicali e di evidenziarne i rischi in un quadro complesso e dominato dalla paura. È il caso della vittoria di Joe Biden in America, della nuova convergenza al centro in Germania, della rielezione di Macron in Francia, del governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi in Italia. Come tutte le vittorie anche queste hanno generato un prezzo da pagare che oggi si chiama inflazione. Un’ascesa del costo della vita, trainata già nel tardo 2020 dai settori della logistica e dell’energia, derivante sia da forme di conflittualità a mezzo di materie prime sia dagli enormi stimoli fiscali post pandemici di Stati Uniti, Cina e Unione europea.
L’invasione russa
Ancora una volta però il demone della politica ha corso più delle soluzioni economiche poiché un altro evento considerato improbabile fino a pochi mesi prima, l’invasione della Russia in Ucraina, ha inaugurato l’anno 2022. Putin ha tentato un colpo di mano non riuscito sul filo-occidentale governo ucraino, ma nello smarrimento di questo obiettivo l’autocrate russo ha comunque messo sottosopra lo scenario politico-economico dei paesi occidentali. In primo luogo si è dovuto fronteggiare la guerra in politica estera, cioè far digerire all’opinione pubblica costose sanzioni alla Russia e la fornitura di armi occidentali all’Ucraina e poi, in seconda battuta, affrontare la crisi energetica sia sul fronte interno che su quello dell’approvvigionamento. Il taglio dei rapporti con la Russia ha determinato un vero e proprio shock in molti dei gruppi dirigenti dei grandi paesi europei, con la fine immediata di una ostpolitik durata due decenni. Ma il versante russo ha scomposto anche tutti gli altri teatri con la crisi del grano in Africa, il ritorno dell’immigrazione in Europa, la avances cinesi su Taiwan, la destabilizzazione del regime iraniano, le mire imperialistiche turche, egiziane e indiane nei territori limitrofi e in generale un discorso pubblico ovunque più improntato alla sicurezza e alla sovranità statale.

Uno dei paradossi di questa evoluzione è senza dubbio il rapporto tra politica e settore energetico. Dopo anni di spinta delle rinnovabili da parte della politica globale e della finanza internazionale con conseguente sospensione degli investimenti nel fossile, la guerra ha scoperchiato tutte le fragilità dell’agenda green dei paesi occidentali. Le rinnovabili, benché in crescita, risultano insufficienti a coprire il fabbisogno energetico e per di più si compongono di materiali quasi interamente controllati dalla Cina. È chiaro che per i prossimi due o tre decenni almeno il mondo non potrà privarsi di gas, petrolio e nucleare e che molti aspetti punitivi della legislazione green - dalla chiusura delle centrali a gas, a carbone e nucleari fino ai disincentivi verso il motore a scoppio - sono insostenibili sul piano economico e sociale nella condizione di emergenza aperta dal conflitto in Ucraina. La guerra ha riportato alla realtà ciò che la pandemia, e la furia di accoppiare spesa pubblica e ideologia da parte dei governi occidentali, avevano proiettato nella sovrastruttura utopica.
La transizione ecologica, visto anche il volume degli investimenti, è ancora possibile, ma in forme diverse, più mescolate e meno accelerate. L’inflazione ha inoltre reso palesi altri due fattori: il primo è che una politica monetaria sempre espansiva, con tassi d’interesse a zero o quasi, non è sostenibile per lunghi periodi e che, al tempo stesso, un’economia sempre più immateriale e digitale non può fare a meno proprio delle materie prime. Chi le controlla, come Russia, Cina e Stati Uniti, gode di un vantaggio competitivo sia politico che economico. Sono due dati di fatto che anche i mercati finanziari hanno dovuto digerire e scontare. In questo scenario inflazionistico, di conseguenza, le banche centrali si ritrovano ad alzare i tassi, a ridurre i propri bilanci, mentre l’economia rallenta e gli Stati si trovano a governare debiti pubblici sempre più ingombranti e bilanci occupati dalla lotta al caro energia.
Verso un nuovo paradigma
Tuttavia, l’economia va sempre letta dentro un quadro politico e culturale più ampio. L’era neo-liberale e della globalizzazione è arrivata definitivamente al capolinea, mentre il mondo sta entrando dentro un nuovo interregno, una transizione dai contorni in parte chiarissimi e in parte ancora sfumati. Il ritorno dello Stato nell’economia e la resistenza della sovranità in alcuni settori (tecnologia, energia), la crescita del protezionismo e la rottura delle catene del valore globale, l’unificazione dei nemici dell’Occidente in Cina, Russia e Iran, la crescita di alcune potenze del “mondo di mezzo” come Turchia e India ci consegnano un mondo a metà strada tra il breve periodo di pluralismo disordinato durato dal 2008 al 2022 e un mondo che sembra tendere al riordino bipolare, con una spaccatura più netta tra l’Occidente allargato e tutti gli altri. È in questo nuovo quadro che mutano anche confini e possibilità per la politica. Sull’energia sarà possibile agire più al di fuori degli schemi convenzionali e ideologici, con la realtà effettuale della cosa che prevale sull’agenda green, con necessità di diversificazione all’interno di un nuovo paradigma securitario e strategico della ragion di Stato.

Lo stesso vale per la tecnologia e i suoi componenti - dai minerali ai semiconduttori - dove uno stato di natura hobbesiano a livello globale costringerà a virare verso la real politik al fine di non restare indietro o almeno di limitare i danni, anche in una logica di aggregazione sovranazionale in Europa o di cooperazione tra le due sponde dell’Atlantico. In forma simile, la sovranità si manifesterà per le infrastrutture strategiche: resistenze nimby e riluttanza ad investire nel lungo periodo dei governi dovranno essere superate in nome dell’emergenza e della logica della decisione nello stato d’eccezione. Se la sovranità statale si espanderà probabilmente su questi fronti, essa sarà ben più limitata su tutto il resto. I valzer internazionali in cui tutte le nazioni ballano con tutte non sono più ammissibili, con profondi riflessi sulla politica interna degli Stati. Non si deve dimenticare infatti che mentre nel caos pluralistico la sovranità degli Stati, quelli più forti in particolare, tende all’assoluto, al contrario in uno scenario di ordine bipolarizzato si vira verso un sistema a sovranità limitata per tutti tranne che per l’America. Ciò significa che la potenza egemone sarà meno incline a tollerare sbandate a favore dei nuovi nemici, sia in politica estera che interna. Il metus hostilis, la paura del nemico come elemento unificante, tornerà ad essere il collante della lega atlantica, con l’America più influente che mai nel limitare la sovranità degli stati europei. Non siamo ancora arrivati a questo punto di semplificazione del quadro, ma potremmo arrivarci presto, specie se la futura pace in Ucraina non sarà solida e stabile e se il rafforzamento totalitario di Xi lo spingerà verso una maggiore aggressività militare. Siamo attualmente in uno stato intermedio, in cui le relazioni internazionali sembrano offrire una sorta di “pluralismo razionalizzato”, non più il disordine iniettato dai nuovi autoritarismi sulla scena globale di qualche anno fa ma nemmeno l’emersione di un nemico unico con conseguente bipolarismo quanto piuttosto un blocco riunificato che fronteggia un numero limitato di avversari. Scenario in cui la potenza egemone americana acquista comunque un peso maggiore sulla galassia di “Stati seguaci” filo-atlantici rispetto al recente passato. I futuri sviluppi geopolitici indicheranno quanto la transizione avviatasi nel 2022 sarà stata breve e quanto capace di innescare nuovi equilibri, rotture, rischi e instabilità.

