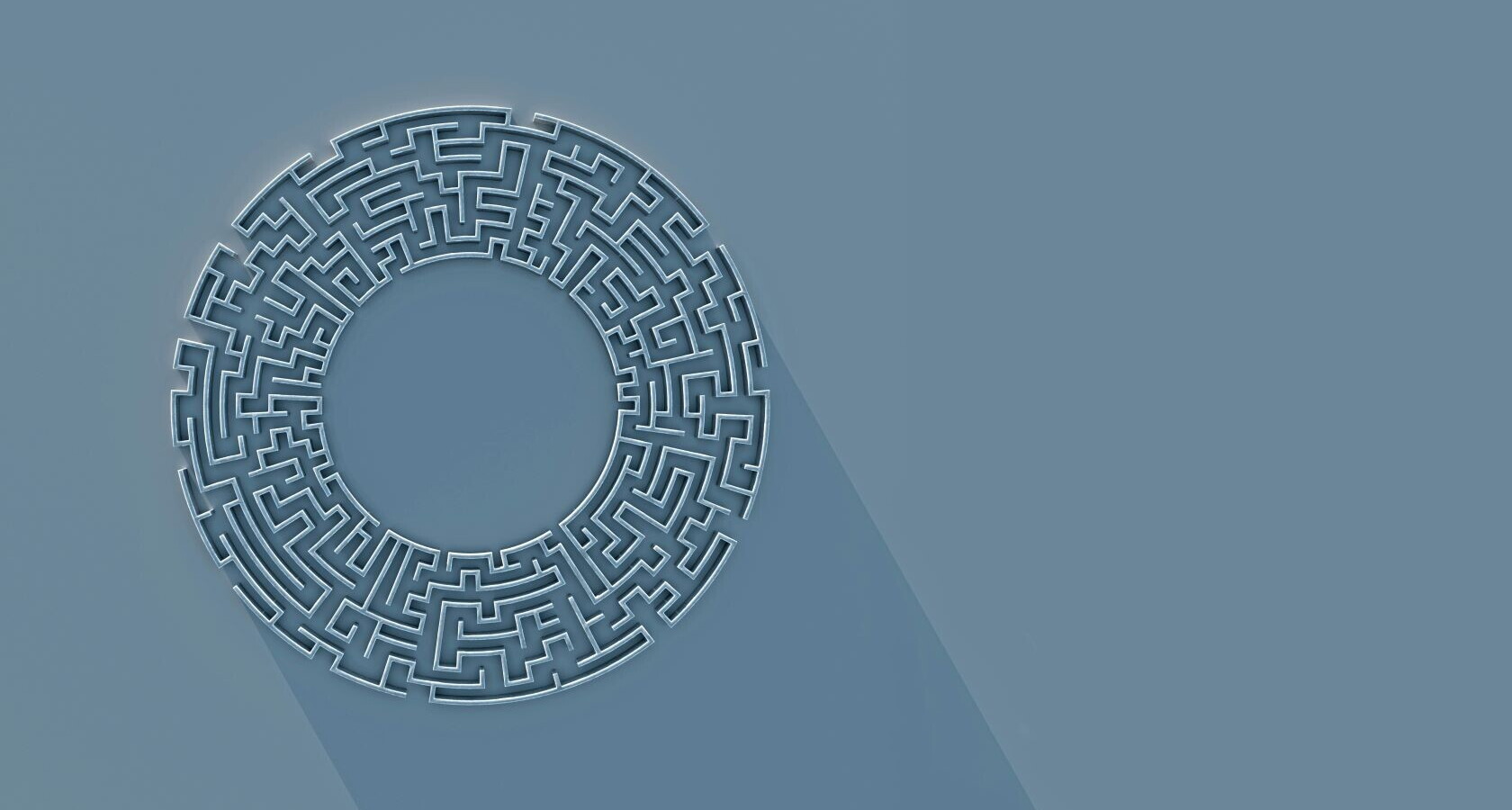L'intervista
Il futuro dell’energia
Le tendenze che caratterizzeranno il panorama globale nei prossimi anni raccontate da Daniel Yergin, uno dei più stimati analisti del settore a livello mondiale e autore del libro vincitore del premio Pulitzer “The Prize: Epic Quest for Oil, Money and Power”
13 minD
aniel Yergin, vicepresidente di S&P Global, è uno dei più stimati analisti mondiali della politica e dell’economia dell’industria energetica. È presidente della famosa CERAWeek, la conferenza sull’energia che ogni anno riunisce a Houston leader aziendali, politici, analisti e media influencer. Yergin è uno scrittore prolifico e il suo ultimo libro (“The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations”) è stato descritto come “una master class su come funziona il mondo”. È inoltre autore del libro vincitore del premio Pulitzer “The Prize: Epic Quest for Oil, Money and Power”, di cui è da poco uscita una nuova edizione con un nuovo epilogo sulle lezioni di “The Prize” ancora valide oggi, disponibile per la prima volta anche in versione audiolibro.
Quali sono, secondo lei, le principali differenze tra la politica energetica promossa dalla seconda amministrazione Trump e quella di Biden?
Vi sono differenze sostanziali. Sotto l’amministrazione Biden la produzione di petrolio e gas naturale è aumentata, così come le esportazioni di GNL, soprattutto verso l’Europa. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza energetica. Tuttavia, l’obiettivo primario dell’amministrazione Biden è stato il clima, un mandato pangovernativo tanto per l’energia quanto per i trasporti. Di contro, l’amministrazione Trump si concentrerà sul potenziare la produzione di energia tradizionale e sui progressi del nucleare, oltre che sulla riduzione delle normative, aumentate molto negli ultimi quattro anni. Porrà molta attenzione su questi aspetti e si focalizzerà sull’energia come elemento cardine della posizione dell’America a livello globale.
Quali sono le principali tendenze che caratterizzeranno il panorama energetico mondiale nel prossimo decennio?
Se dovessi scegliere, direi il rapido ritmo di crescita della domanda nel Sud del mondo, il crescente ruolo rivestito dal GNL, l’aumento dell’importanza delle rinnovabili nel mix energetico, il riacceso interesse per l’energia nucleare e la lotta per la ricerca di un equilibrio tra fabbisogno energetico e politiche climatiche. Per non parlare poi dell’impatto generato dall’IA. Sono due i grandi interrogativi: cosa succederà alla domanda di energia? E cosa al mix energetico in Cina e in India? Sul tema dei veicoli elettrici, la Cina avrà un ruolo predominante in gran parte del mondo.
A oggi circa il 2 percento dell’energia primaria totale del mondo è fornita dall’eolico, dal solare e dal geotermico. Come stima si modificherà questa cifra nel 2035?
Dobbiamo aspettarci senz’altro un aumento. Grazie all’entità della produzione cinese, i costi dell’energia solare sono diminuiti drasticamente. Inoltre, le tecnologie eoliche hanno fatto passi da gigante.

Quale ruolo crede che giocherà il nucleare nel futuro mix energetico?
È davvero sorprendente vedere il cambio di attitudine nei confronti dell’energia nucleare e la crescente convinzione che abbia un ruolo importante da svolgere, sia che si tratti di centrali tradizionali, di piccoli reattori modulari o di fusione. Tale cambiamento è ben visibile nel fatto che 28 Paesi intendono triplicare i numeri del nucleare entro il 2050.
Google, Microsoft e Facebook stanno tutti esplorando le strade del nucleare: ha un’opinione sull’infinita guerra tra grandi reattori e piccoli reattori?
I reattori tradizionali sono una tecnologia e un’industria di lunga data. Ci si concentra molto sul potenziale dei reattori nucleari di piccole dimensioni (SMR), sia con un design simile agli attuali reattori ad acqua leggera sia con approcci diversi, ma l’impatto degli SMR diverrà palese solo nel prossimo decennio.
Un tempo eravamo soliti immaginare che una qualsiasi guerra in Medio Oriente avrebbe mandato nel caos il mercato del petrolio. A un anno dall’inizio di quest’ultima guerra, il conflitto si sta ampliando, ma il mercato energetico non è sprofondato nel caos. Perché?
Mai dire mai: le cose potrebbero cambiare da un giorno all’altro. È comunque degno di nota il fatto che finora i mercati non abbiano reagito con un’impennata dei prezzi come ci si sarebbe aspettati in passato. A mio avviso, sono tre le ragioni. La prima è la rivoluzione dello shale, di cui parlo nel mio libro The New Map. Oggigiorno gli Stati Uniti sono di gran lunga il maggior produttore di petrolio al mondo e questo è un fattore di stabilizzazione. La seconda è l’esistenza di una sostanziale capacità inutilizzata, almeno in questo momento, sul lato arabo del Golfo Persico. La terza riguarda la debolezza dell’economia cinese e l’incertezza sul futuro andamento della domanda di petrolio in Cina, che nei decenni precedenti era responsabile della metà della crescita annuale di tale domanda. Attualmente, i mercati sono segnati da un eccesso di offerta, ma bisogna tenere presente che l’equilibrio tra domanda e offerta non è statico e può cambiare per molte ragioni.
In che modo questo conflitto potrebbe ancora rimodellare i mercati energetici globali nei prossimi anni?
Il 6 ottobre 2023 il Medio Oriente si avviava verso uno storico riequilibrio geopolitico. L’attacco di Hamas del 7 ottobre mirava tra le altre cose a impedire questo riequilibrio. Qualunque cosa accada, il Medio Oriente sarà ancora cruciale per l’energia mondiale per molti decenni a venire; inoltre, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti dispongono di un nuovo vantaggio competitivo: energia elettrica a basso costo.
L’ampia e rapida adozione dell’intelligenza artificiale ha creato un aumento massiccio e senza precedenti della domanda di energia. Una ricerca tramite IA consuma fino a dieci volte l’energia di una ricerca standard su Google. Il mondo sarà in grado di produrre energia sufficiente per rispondere adeguatamente a questa domanda crescente?
Alla conferenza CERAWeek che si è tenuta a Houston nel marzo 2024, l’IA sembrava essere arrivata quasi dal nulla per dominare l’agenda. S&P Global stima che i data center potrebbero essere responsabili del 7-10 percento della domanda totale di elettricità negli Stati Uniti entro il 2030. A quella data mancano solo cinque anni. Questa realtà è uno dei fattori che ha generato una rinnovata attenzione per l’energia nucleare, trainata dalle grandi aziende tecnologiche. Come verrà soddisfatta questa nuova domanda di energia è un grosso punto di domanda. A questo punto, ritengo si tratterà di un mix di gas naturale, energia eolica e solare, batterie, nucleare... e di una nuova spinta verso soluzioni tecnologiche capaci di ridurre la richiesta di energia elettrica.

Molti Paesi e aziende, dal Giappone alle grandi società tecnologiche, si sono impegnati a raggiungere lo zero netto di emissioni di CO2 entro il 2050. Crede che si stiano pentendo di aver fatto questa promessa?
Non posso chiaramente sapere cosa pensino... ma va precisato che diversi dei Paesi responsabili per il 45 percento delle emissioni non hanno obiettivi “zero netto” per il 2050, bensì per il 2060 e il 2070. Di recente abbiamo scritto un nuovo articolo su Foreign Affairs sul perché si debba ripensare l’intera idea di “transizione energetica”. Non si sta dimostrando lineare, come alcuni scenari propongono, ma multidimensionale, con Paesi diversi che viaggiano a ritmi diversi, con mix diversi di tecnologie e con priorità diverse. Credo in generale vi sia la consapevolezza che trasformare in un quarto di secolo quella che attualmente è un’economia mondiale da 115.000 miliardi di dollari sia estremamente ambizioso. Estremamente... e con stime dei costi molto diverse tra loro. La traiettoria può essere chiara, ma non lo sono i tempi.
Come immagina il futuro delle grandi compagnie petrolifere e del gas? Per cosa saranno conosciute le principali compagnie energetiche nella prossima generazione?
Penso che tra una generazione saranno ancora nel business della fornitura di petrolio e gas, perché il mondo continuerà a utilizzarne in quantità sostanziali. Tuttavia, queste compagnie sono in fondo aziende tecnologiche, società che operano in ambito ingegneristico, e credo che rivestiranno un ruolo più ampio nel fornire l’energia di cui il mondo avrà bisogno tra una generazione. Mi colpisce sempre il fatto che molte persone non riconoscano che si tratta di aziende tecnologiche: possiedono le dimensioni, possiedono il talento. Eppure, la strada per il futuro non è mai dritta.
Come vede l’equilibrio tra sicurezza energetica e preoccupazioni ambientali? La pressione per la decarbonizzazione sta rendendo Germania, Corea del Sud, Giappone e Taiwan più deboli rispetto a Russia e Cina?
La sicurezza energetica non è stata oggetto di discussione nel periodo della pandemia di Covid 19. I prezzi sono crollati, così come la domanda. Ora però è tornata alla ribalta ed è una preoccupazione costante. È chiaro che i governi hanno dovuto adattare i propri obiettivi climatici di fronte ai rischi riguardanti la sicurezza energetica e che dovranno trovare un nuovo equilibrio. Il Giappone si è distinto come nazione più trasparente nel palesare questa necessità; per l’Europa, questa è una preoccupazione di primaria importanza se intende scongiurare la deindustrializzazione.
In che modo la rapida crescita dei veicoli elettrici potrebbe avere un impatto sull’industria petrolifera e sulle dinamiche energetiche globali?
La ripresa dei veicoli elettrici è stata molto disomogenea - almeno finora, stando al nuovo Pulse of Change di S&P, che tiene traccia della diffusione dei veicoli elettrici. La Cina è molto avanti, considerando che oltre il 50 percento delle vendite di auto nuove riguarda veicoli elettrici. L’Europa si assesta al 20 percento circa e gli Stati Uniti al 10 percento. Ad oggi, quindi, l’impatto maggiore ha riguardato la crescita della domanda di petrolio cinese, fattore chiave nel mercato globale.
Come vede l’impatto dei dazi proibitivi sui veicoli elettrici cinesi in Europa e in Nord America?
Sia gli Stati Uniti sia l’Europa temono un’inondazione di veicoli elettrici cinesi a basso costo alla conquista di quote di mercato, a danno delle industrie nazionali. Questo è un problema soprattutto per un Paese come la Germania, dove l’industria automobilistica assume estrema rilevanza. Tuttavia, l’Europa deve anche preoccuparsi delle ritorsioni da parte della Cina, che inciderebbero sulla capacità dei produttori europei di vendere automobili nel Paese asiatico.
Quali sono, secondo lei, i luoghi comuni più significativi sull’industria energetica che persistono nel dibattito pubblico?
Ve ne sono molti, senza dubbio. Ma mi permetto di citarne tre. In primo luogo, non ci si rende conto di quanto l’energia sia fondamentale per l’economia in generale - e non solo per i trasporti. Secondariamente, non si ha comprensione del mix di energie: gli idrocarburi rappresentano ancora oltre l’80 percento dell’energia totale mondiale. Infine, si sottovaluta la complessità e la tempistica della transizione energetica, nonché la differenza di priorità tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo.